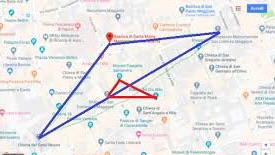Fermata Sannazzaro. Scesi. Il tragitto era stato più lungo del previsto, avevo preso il primo autobus disponibile, quello per “Riviera di Chiaia”, pensando di non aver fatto la scelta giusta: con la Metro 2, avrei fatto prima, ma, poi, l’assenza del traffico e la vista del mare mi avevano fatta ricredere.
“Ci siamo” pensai, avevo appena imboccato “Salita di Grotta”, pochi passi ancora e sarei giunta davanti alla galleria che separa il centro dalla periferia. Non sapevo bene a che altezza, ma doveva essere sulla sinistra poco prima del tunnel. Poi, finalmente, lo vidi: un imponente cancello di ferro battuto emergeva da prorompenti edere. Non c’ero mai stata, ma era proprio come me l’ero sempre immaginato. Un piccolo, palpitante cuore verde nascosto nel duro petto della città. Lo varcai e fui avvolta dall’ombra.
Napoli è così: un attimo prima, avverti il sole caldo sulle palpebre che ti abbaglia e ti disorienta e, un secondo dopo, ti ritrovi tra vicoli o antri che sembrano non esser mai stati toccati dalla luce. Rabbrividii, ma questo non fermò il mio incedere: la serpentina che, dolcemente, saliva, tra alberi e cespugli, mi invitava a intraprendere il cammino, a raggiungere la cima, a ritrovare il sole.
“Cosa cerchi?” mi chiese un uomo accovacciato al suolo sul ciglio della strada, senza però alzare lo sguardo dal terreno che stava smuovendo.
Non sapevo da dove fosse sbucato e la sua improvvisa presenza mi spaventò più del fatto di essere sola, ma pensai fosse il custode del parco e così risposi “La tomba di Virgilio, grazie”
“Tutti che avete così fretta di andare alla tomba e non sapete neanche la differenza tra un giunco e una marruca”
“Un giunco e…” stavo accenando, ma, poi, notai ciò che aveva tra le mani. Semi. Stava piantando qualcosa. Doveva essere il giardiniere, allora. Facendo due più due, dissi “Piante! Sono piante!”
“Brava! L’osservazione è un’ottima dote. Ma la conoscenza richiede impegno. Un giunco sopravvive in ambienti acquitrinosi, poco ospitali, una marruca al contrario in ambienti luminosi, l’uno appare insulso quanto l’altra splendente, eppure, il primo può avere svariate applicazioni e l’altra, dietro ai suoi invitanti fiori, nasconde delle insidie”
“Mi sta dicendo che non devo fermarmi alle apparenze?”
“Vedo che anche l’intuito funziona” solo in quel momento, mi mostrò i suoi lineamenti levigati, quasi marmorei, il suo sguardo fermo ma rassicurante. Non so perchè, ma anche se non l’avevo mai visto prima, qualcosa in lui, mi risultava familiare.
“Se sai della tomba, sai anche che, all’interno, non c’è niente. Giusto?”
L’uomo si alzò e mi invitò a guardare lo scorcio che era dinnanzi a noi oltre il ballatoio e che fino a quel momento non avevo notato.
“Non è bellissima?” continuò con lo sguardo perso verso la città.
“Chi?” chiesi disorientata, ma l’uomo sembrò non far caso al mio interrogativo, con lo sguardo perso davanti a sé.
“Quando vi giunsi per la prima volta, è stato come incontrare il vero amore. Neapolis era una splendida donna adagiata sulla riva del mare, ricoperta di vesti smeraldo e ornata di pietre preziose. Così appariva, a chi giungeva al vecchio porto: poche ville e colline verdeggianti, avvolte in una luce invadente. E mentre un calore intenso ti rianimava i sensi, conquistandoti, quello splendido corpo celava, a noi poveri sprovveduti, la sua vera anima. Un’anima tormentata, perennemente in bilico tra la benedizione e il tormento. Ero un giovane uomo di cultura, desideroso di conoscere tutti i segreti del mondo. E tutti i segreti del mondo erano confluiti nei suoi quartieri, piccoli capillari traboccanti di sangue proveniente da ogni luogo allora conosciuto.”
“Continuo a non capire…” tentai, ma lo sconosciuto, come se non l’avesse neanche percepito, riprese
“È in questa città che il mio maestro, Sirone, tra i portici della sua scuola, da semplice poeta che ero, il mantovano Publio Virgilio Marone, mi ha iniziato alla filiosofia epicurea e reso Virgilio Mago.”
“Vorrebbe farmi credere che è un poeta vissuto circa duemila anni fa?”
“Poeta e… mago, proprio come ho detto.”
“E naturalmente è ancora qui perché ha scoperto l’elisir di lunga vita!”
“Mi sarebbe sempre piaciuto poter dire di averlo scoperto io, ma non è stato così, il merito è del mio maestro: mi ha reso un custode di questa città”
“Il mistero del Castel dell’Ovo?” dovevamo essere entrambi impazziti, ma di certo quando quella mattina avevo deciso di visitare il Parco Vergiliano, tutto mi aspettavo fuorchè quell’insolito risvolto. E volevo capire cos’altro si sarebbe inventato.
“Quella è una storiella che le nonne amavano raccontare ai bambini: secondo te, avrebbe potuto mettere un uovo in una gabbia, nasconderlo nelle fondamenta di Megaride, per proteggere questa città? L’hai fatto davvero, amico mio?”
Un altro omino di mezza età, dall’andatura incerta, ma lo sguardo vispo come quello di un bambino e il sorrisetto beffardo di un vecchietto, avanzava verso di noi. Aveva un taccuino tra le mani e un libello nel taschino.
“E lui è il mio amico Giacomo…”
“Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi, lieto di fugare qualche dubbio o di indurne qualcuno…”
Ormai, era veramente troppo, non avevo la minima idea di come fosse Virgilio, ma vi assicuro che quella era proprio la copia esatta del poeta de L’Infinito.
“Oh, sì! Io sono morto davvero, se è quello che stai pensando, e la mia tomba è qualche gradino più in basso a destra, se ti va di venirmi a salutare di tanto in tanto. Anzi la mia passeggiata quotidiana è terminata. Buon proseguimento!”
Cosa stavo pensando? Ormai, non pensavo più nulla. Ma intendevo vederci chiaro.
“E la sua tomba, invece, dove sarebbe?” chiesi al giardiniere-poeta-mago
Mi indicò un piccolo edificio di tufo che svettava sopra le nostre teste, a mò di una torretta di avvistamento col tetto a cupola
“Un colombaio abbandonato? Tutto qui?” risposi delusa.
“Non fermarti alle apparenze. Ricordi?” Ripensando al giunco e alla marruca, mi feci guidare fino al suo interno. Varcai la soglia. L’ambiente circolare era umido per la poca luce che filtrava dalle finestre ma caldo per delle piccole fiammelle che provenivano da un braciere centrale.
Perchè mi trovavo, lì? Cosa stavo cercando?
Il sedicente Virgilio si avvicinò al fuoco e gettò alcuni semi che estrasse da un sacchetto legato alla cintola. Mi invitò a fare lo stesso.
Ne presi una manciata e li gettai a pioggia sul catino rovente, ma questi, invece di riversarsi rapidamente, rimasero come sospesi.
Io, mi sentivo sospesa: potevo sentire i piccoli chicchi, carichi di vita, che attraversavano l’aria e vedevo distintamente, in un tempo, infinitesimale, quei puntini neri avvicinarsi, uno alla volta, alle lingue di fuoco; quando il primo sparì, un’enorme mosca d’oro apparve davanti ai miei occhi, ingurgitando uno sciame di piccoli suoi simili che infestavano l’aria; quando fu la volta del secondo granello, vidi un serpente gigante diffondere panico per le strade della città per poi essere ricacciato nelle viscere della terra; il terzo, mi mostrò la gioia degli abitanti di Partenope, ebbri delle acque sorgive sgorgate dalle grotte Platamonie; vidi, ancora, la collina di Posillipo, alle mie spalle, squarciarsi, nel bel mezzo di una notte buia, in una cripta per centinaia di metri e, poi, il sole attraversarla, da parte a parte, per annunciare al mondo la venuta della primavera e dell’autunno.
Un seme dopo l’altro, si rivelarono questi ed altri prodigi attribuiti da secoli al poeta mago. Ero curiosa di scoprire cosa dovesse ancora rivelarmi l’ultimo, ma di colpo le fiamme si spensero.
Avvertii l’insensato bisogno di sedermi, portare le gambe al petto e fasciarle con le braccia. Chiusi gli occhi e fui avvolta da un lieve tepore, da un silenzio acquoso. Mi sentii come in un grembo materno, in un uovo, un seme. Ero dentro le viscere della terra. Sotto le fondamenta stesse della città. Non so se viva o morta. Non so se al principio o alla fine di tutto.
Fui svegliata dalla vitalità della città. I clacson impazziti, i motorini che sfioravano i finestrini, quasi stridendo contro la carrozzeria, le fugaci battute tra viaggiatori sconosciuti, il caldo appiccicoso di un autobus, all’ora di punta, in un ordinario giorno di mezza estate. Rinvenni a fatica. Chiesi a quale fermata ci trovassimo. Eravamo quasi al capolinea. Dovevo essermi assopita e aver girato per tutta la città ritornando al punto di partenza.
Allora, era stato tutto un sogno. Il mezzo si fermò, ma ero troppo stordita per alzarmi subito. Aspettai che scendessero prima tutti gli altri passeggeri, e poi mi decisi. Fu in quel momento che lo vidi. Sul sedile, accanto al mio, c’era un mazzetto, un insolito bouquet. Non avevo mai visto quella varietà, ma qualcosa mi diceva che si trattasse di steli di giunco e fiori di marruca.
Realtà, sogno, leggenda…non lo so, ma se vi capitasse di trovarvi nei pressi di Piedigrotta, precisamente al civico 20 di Salita di Grotta, e tra gli alberi di quel parco nascosto doveste incontrare due insoliti personaggi, non dimenticate di salutarmeli.